Ani, domenica 16 agosto 2009
Ci svegliamo a Doğubayazıt in una splendida mattina. Dall’ultimo piano del nostro alberghetto dove facciamo colazione godiamo di una nuova vista dell’Ararat, distante solo 15 km.
Salutiamo la grande montagna che spero di rivedere tra qualche settimana dalla parte armena.
Ritornati a Kars ci dirigiamo verso Ani, l’antica capitale armena distante 45 km.
Le piste precedenti sono un ricordo: ora possiamo sbizzarrirci in un’autostrada a quattro corsie, costruita di recente e quasi vuota.
A parte qualche carro pieno di fieno.
E le oche presenti da queste parti su strade grandi e piccole.
Si nota invece una novità, un carretto trainato da un cavallo con due grandi ruote e con una specie di rastrello per raccogliere più agevolmente il fieno.
Su una collina l’ennesimo monumento alla patria turca con annessa bandiera.
Combustibile organico ad essicare.
Appena passato il piccolo villaggio omonimo appaiono le possenti mura di Ani, di cui è rimasta in piedi solo l’entrata.
Mille anni fa, al momento del suo massimo splendore, Ani aveva oltre 100mila abitanti e rivaleggiava con le altre metropoli dell’epoca, come Costantinopoli. Arrivando proprio da İstanbul fa un certo effetto vedere questo deserto di rovine.
Costruita su importanti vie di comunicazione, Ani divenne capitale dell’Armenia sotto la dinastia dei Bagratidi nel 961. Nel 1045 cadde sotto il controllo bizantino e nel 1064 capitolò di fronte all’assedio dei Selgiuchidi turchi che ne massacrarono la popolazione. Successivamente Ani passò spesso di mano: la dinastia curda dei Shaddadidi, i Georgiani, l’ennesima distruzione ad opera dei Mongoli da cui iniziò la decadenza, Tamerlano, i Safavidi sciiti fino all’Impero Ottomano. È abbandonata dalla metà del XVIII secolo.
Nell’ampia zona archeologica le rovine più o meno in piedi sono pochissime. Nonostante questo rimaniamo senza fiato. Sapevamo che Ani meritava una visita, ma non ci aspettavamo emozioni così forti.
Il sito è parzialmente delimitato da uno strapiombo sul fiume Akhurian (Arpa Çay in turco) che segna la frontiera con l’Armenia, nei cui pressi si vedono garitte e torrette.
Questa regione è rimasta a lungo una zona militare (fino a vent’anni fa questo era il confine con l’Unione Sovietica) e solo pochi anni fa venne aperta al turismo, pur con molte limitazioni.
Attraversata la cadente porta principale, si vede una distesa di erba con pochissime costruzioni in lontananza.
Le prime garitte. Dall’altra parte del fiume è già Armenia. È sorprendente che non si veda nessuno in giro e che la zona sembri poco presidiata. I contadini raccolgono tranquillamente il fieno poco oltre il sito archeologico.
Immagino come si possa sentire un armeno in visita in questa regione, magari in breve se e quando apriranno la frontiera: l’Ararat, il genocidio, Ani, per cui si deve anche pagare anche un biglietto d’entrata. Il sito archeologico non è tenuto benissimo e si capisce che ai turchi non interessi molto preservarlo.
La Chiesa del Redentore (1034-36) è la prima che si incontra, ovvero solo un moncone di essa.
Era quasi intatta fino a circa cinquant’anni fa, quando gran parte crollò per una tempesta.
Girandoci intorno si vede che a parte i sostegni per evitare ulteriori cedimenti non è stato fatto molto. Dall’interno la semicupola sembra stia per cadere da un momento all’altro.
Poco oltre, in basso su un’ansa del fiume, sorge la Chiesa di San Gregorio l’Illuminatore (1215), ora in ricostruzione.
È l’unica in cui siano ancora visibili degli affreschi.
I tempi sono cambiati. Fino a pochi mesi fa non si poteva venire qui sotto: alle zone del sito archeologico più vicine al confine era proibito l’accesso.
Lo stesso capitava con la Cittadella (İç Kale, VII secolo), che domina l’intero sito sotto la bandiera turca.
Siamo fortunati a poterci salire. Solo da qui si può avere una visione d’insieme di Ani, difficile da ottenere standoci in mezzo. Lungo il percorso abbiamo raccolto dei frammenti visivi che solo da questo punto privilegiato si ricompongono in una visione di insieme.
È difficile immaginare come apparisse questa città al suo apogeo un migliaio di anni fa.
In mezzo al sito appare anche la Cattedrale, a suo tempo sede del Patriarcato Armeno, la cui costruzione risale al 989-1010.
La sua cupola crollò nel 1319.
A seguire la Moschea di Menüçir, con uno strano minareto ottagonale che sembra più che altro una torre.
Poco sopra, vicinissimo, c’è il confine, con le garitte armene.
Il fiume ha scavato un solco nelle colline circostanti.
Sotto, i soliti animali brucano nei pressi dell’altro fiume (Alaca) oltre le transenne del sito.
Un’altra chiesa dedicata a San Gregorio (fine del X secolo) stavolta con la cupola intatta, ma non il resto.
All’interno si vedono dei graffiti armeni di inizio Novecento.
Siamo quasi alla chiusura. Una guardia del sito fa un giro di ispezione… in ciabatte.
Furio fa notare che abbiamo visto gente lavorare in giacca e cravatta, pastori in giacchetta e muratori che lavoravano in cantiere in pantofole.
Riprendiamo la strada per Kars, tra mandrie di mucche di passaggio.
Un altro mausoleo turco.
E carri trainati da cavalli.
Facciamo però una deviazione per cercare delle chiese armene perse nei paesini del circondario. Prendiamo una stradina disfatta tra panorami di campi ubertosi e laghetti sperando che la Hyundai tenga ancora per qualche ora.
Le solite oche
Ogni tanto qualche rapace.
Siamo entrati in un’altra dimensione, ancor più rurale, in piena steppa. Parabole dappertutto, ammassi di torba.
Ci chiediamo se gli abitanti di questi villaggi abbiano visto qualche occidentale negli ultimi anni.
Le famose chiese armene sono dei ruderi abbandonati in mezzo ai villaggi.
Ma non possiamo neanche scendere per la presenza di moltissimi cani incazzati in ogni paesino.
Ormai il sole sta tramontando ed è ora di tornare verso la strada principale evitando di rimanere impantanati in qualche villaggio.
Come sempre arriviamo a Kars al buio, giusto in tempo per riconsegnare la Hyundai (in uno stato pietoso, come previsto).
Cerchiamo un ristorante per gli ultimi kebab, visto che domani sera se tutto va bene saremo già in Georgia. Nessuno ci convince e poi ne infiliamo uno senza renderci conto del nome: si chiama “Ani Ocakbaşi”.































































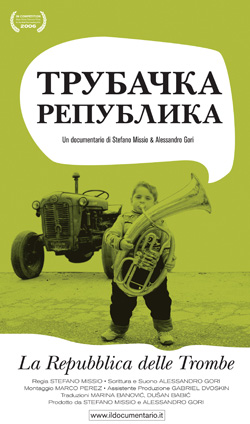
Lascia un commento